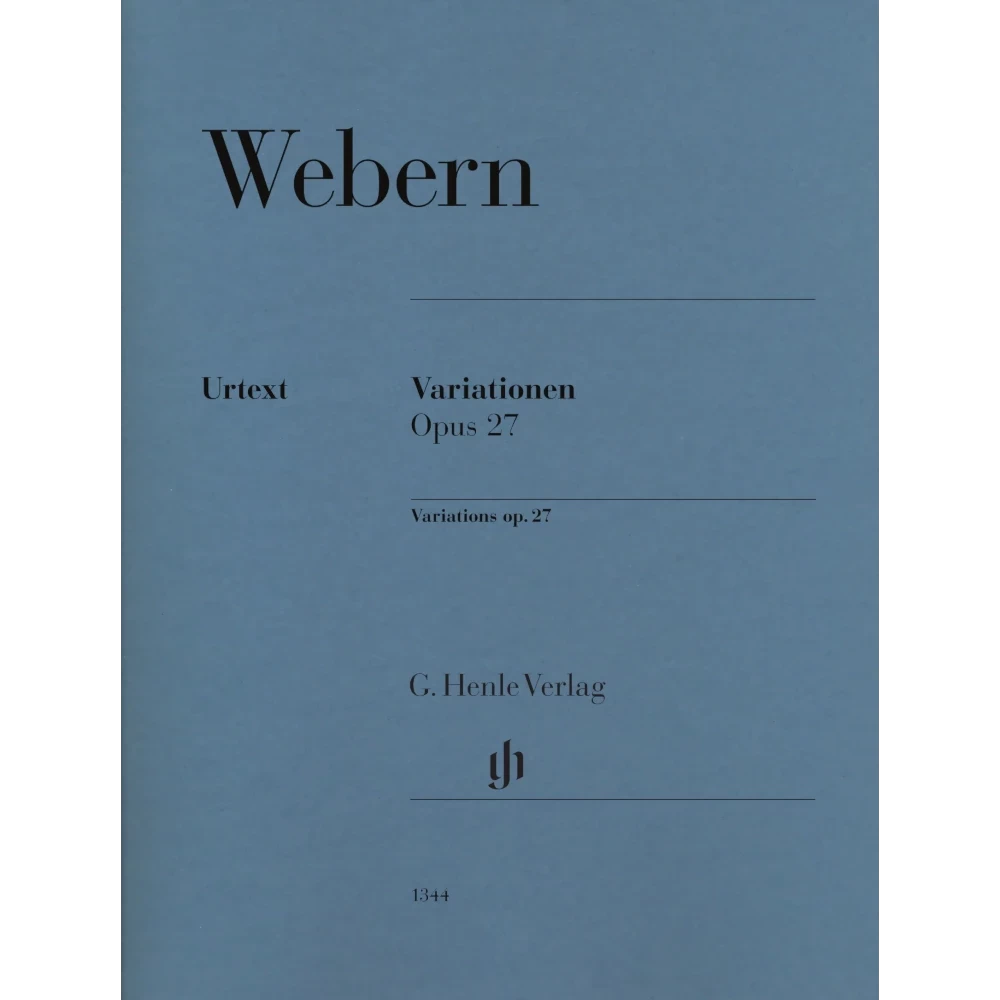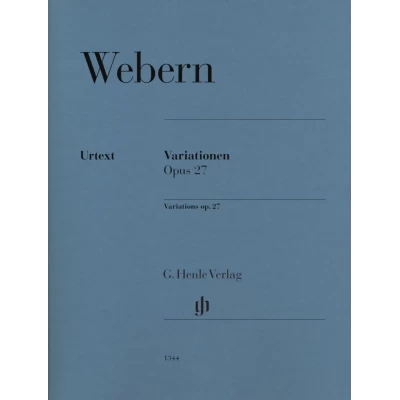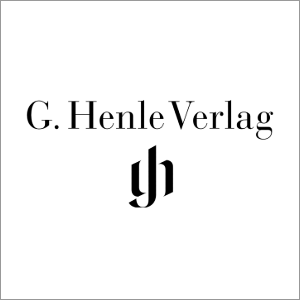I cento e passa anni che dividono le Variazioni di Beethoven dalle Variazioni op. 27 di Anton von Webern, completate nel 1936, non possono cancellare la discendenza ideale tra l'ultimo Beethoven e la seconda scuola viennese. In questi dieci minuti, che rappresentano l'intera opera pianistica dell'autore, la volontà di concentrare nella cellula o nella singola nota significati che le forme musicali avevano enucleato nel corso di secoli, sconfina nell'utopia. La gerarchia è soppressa e il tema è già variazione o, per dirla con Leibowitz, «in quest'opera tutto è variazione, o ancora (ciò che fa lo stesso) tutto è tema». li primo movimento è tripartito, ma la ripresa ribalta lo schema ritmico. La sezione centrale è una giga a forma di canone per moto contrario. Il terzo movimento, infine, condensa a sua volta la serie originale e cinque variazioni. Scrivendo ad Hildegard Jone per annunciare di aver terminato la seconda parte del pezzo, Webern notava: «Ciò che tu dici del tempo e della distanza come misuratori dell'arte, in contrapposizione al campo dove essi invece vengono misurati, esprime davvero tutto». Pur non conoscendo quanto la Jone aveva scritto al compositore, possiamo ben comprendere la risposta di questi. È il rapporto nuovo che la seconda scuola viennese postulava nei confronti della storia e della storicizzazione dell'opera d'arte e nell'opera d'arte che costituisce il legato maggiore della nuova musica, e di quella weberniana in particolare.
Bruno Cagli